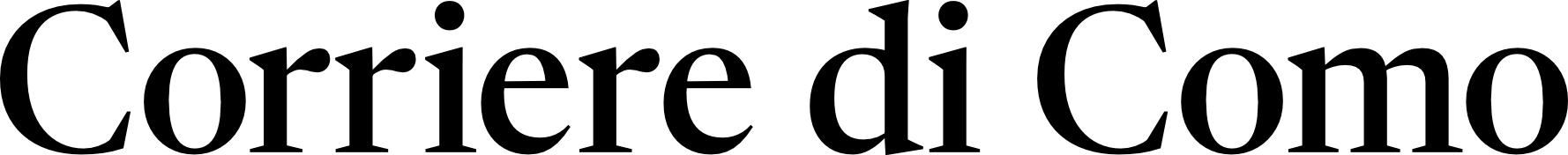Il pranzo è servito con i due Plinii

Il latino ci salva la vita perché fa parte del nostro Dna culturale e ci riempie la pancia. Accendi la tv e un fiume di ricette, cuochi e pasticceri stellati o più o meno improvvisati ti invade il salotto, il tinello, la cucina. Ma l’antica Roma riserva tantissime sorprese al gourmet curioso che non si accontenta di Marchesi, Artusi e compagnia cucinante e vuole andare indietro nel tempo, alle radici del gusto. Certo dovrà rinunciare alle patate, ai pomodori e al cacao. Ma cosa mangiavano e come cucinavano duemila anni fa i nostri maiores Romani? Ecco venirci in soccorso con un caleidoscopio di spunti, curiosità e informazioni storico-letterarie il volume appena edito da Ares e opera di Silvia StucchiA cena con Nerone(pp. 240, 14 euro, disponibile su carta e in ebook, di agile formato da tenere in borsetta e sullo scaffale accanto ai fornelli) che propone un’immersione nella cucina repubblicana e imperiale, sia con una scelta di passi letterari, sia con autentiche ricette ricavate dalle opere di Catone, Columella, e, soprattutto, da Apicio, sotto il cui nome ci è giunto il più famoso corpus gastronomico.Ma la cucina romana non è soltanto cene luculliane alla Trimalchione o alla Nasidieno, come suggerisce il libro.E molte pagine di questa esperta latinista bergamasca fanno riferimento ai due nomi che tengono alto il vessillo della comacinità nel mondo dell’antica Roma ossia Plinio il Vecchio e suo nipote Plinio il Giovane. Vediamo quali.Silvia Stucchi ad esempio ci rammenta proprio all’inizio della sua narrazione culinaria che è un viaggio davvero sui generis nell’antica Roma che qualcuno ha voluto vedere nei formaggi descritti da Plinio il Vecchio (di cui ci apprestiamo a festeggiare il bimillenario della nascita), autore dellaNaturalis historiain 37 volumi che fu la summa enciclopedica del sapere scientifico antico, «gli antenati del parmigiano e del pecorino». Il riferimento è all’undicesimo libro di questo monumentale volume pliniano.L’autrice dedica un intero capitolo a Plinio conoscitore di formaggi, sulla scorta di quanto ci ha consegnato nel capitolo 97 dell’undicesimo libro del suo enorme trattato. Pur con le difficoltà di far corrispondere una descrizione di duemila anni fa a quanto troviamo oggi sul bancone del mercato, ecco un profluvio di formaggi gallici già all’epoca rinomati, e poi quelli prodotti su Alpi e Appennini. Molto rinomato per Plinio era il formaggio di Luni, forse antesignano del parmigiano chiosa l’autrice. Ma attenzione. «Non si fa formaggio con il latte degli animali che hanno i denti sia sulla mandibola che sulle mascelle – ammonisce Plinio – perché il loro latte non caglia»I romani conoscevano lo yogurt? All’epoca qualcosa di simile si chiamava “melca” e ne parlano sia Apicio che Plinio con il suo “latte acido” nel libro ventottesimo della Naturalis. E se si esagera a tavola, specie dopo un pranzo luculliano, col cavolo troverete rimedio, come scrive Plinio nello stesso trattato (libro 20) a proposito degli antidoti all’ubriachezza. Preziosa guida gastronomica è anche una pagina del nipote del Vecchio, ossia Plinio il Giovane. Che scrivendo a Setticio Claro ci racconta l’intero menu di una cena: una lattuga, tre lumache, due uova, torta d’orzo con vino melato e neve, e poi olive, barbabietole. zucche, cipolle «e altre mille portate non meno raffinate». «La neve conservata nelle ghiacciaie – scrive l’autrice del saggio – era un lusso».