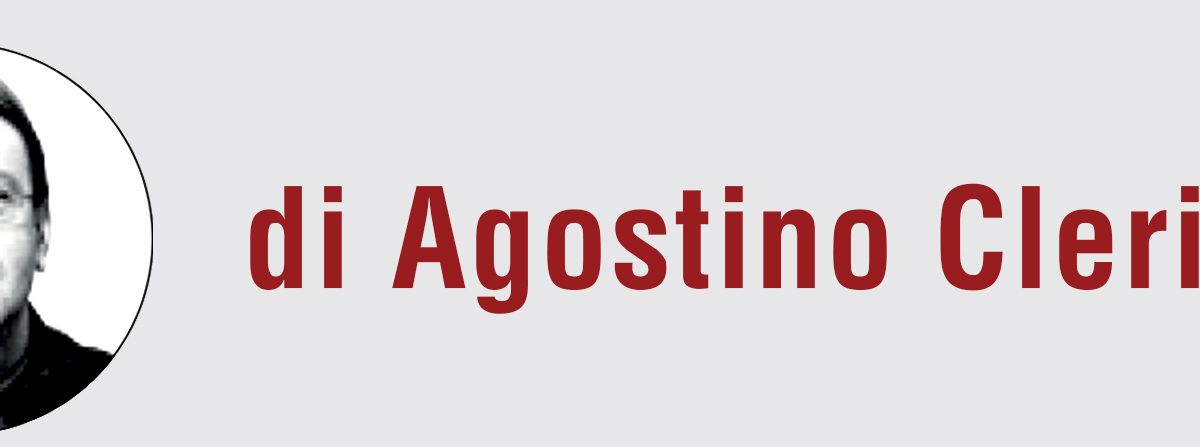Lorenzo Morandotti
Oggi, nella ricorrenza dell’anniversario della scoperta dell’America, l’occasione comasca per celebrare il “Columbus Day” potrebbe essere data da una visita (costa 4 o 2 euro a seconda dell’età) alla Pinacoteca di Palazzo Volpi in via Diaz nella cui sezione rinascimentale è conservato il ritratto di Cristoforo Colombo (nella foto sopra) di autore anonimo, databile attorno al 1516, argomento di discussione fra i dotti e ritenuto una delle immagini più attendibili del grande navigatore. Un tempo il Comune di Como era solito ricordare ai cittadini e ai turisti la presenza di questo documento storico e artistico che faceva parte della collezione di ritratti di uomini illustri dello storico Paolo Giovio, famoso letterato comasco al quale si deve tra l’altro l’odierno concetto di Museo. Per la ricorrenza di oggi però non è stato speso un rigo di comunicato stampa né via web. Una svista? Una dimenticanza? Per carità, il 1992 delle colombiadi è lontano, e ci sarebbero ben altre priorità in agenda, anche sul solo fronte culturale. Però è un dipinto, quello di cui si parla, peraltro già andato più volte in tournée presso mostre dedicate a Colombo e alle scoperte del nuovo mondo. Scrisse Giovio nei suoi “Elogi” a proposito di Colombo: «Chi non si meraviglierebbe che un uomo con un viso così nobile e famoso per la grandezza unica del suo coraggio straordinario per la forza portentosa del suo ingegno smisurato, sia potuto nascere in un villaggio ligure rozzo e disprezzabile come Albissola vicino a Savona?». Perché allora Como si dimentica del suo Colombo, che varrebbe magari un poster, un foulard in seta comasca o analogo souvenir negli Infopoint, e si comporta da villaggio rozzo invece che da grande capoluogo di confine? Negli Usa è in corso da tempo una sorta di revisionismo attorno alla figura di Colombo e ai risultati, invero poco edificanti sul piano umano, della conquista dell’America da parte degli europei, colpevoli di avere sterminato milioni di persone inermi a suon di armi da fuoco e armi a loro ignote come il vaiolo. Si va dietro all’onda? Credo molto più banalmente che sia un caso di poca memoria. Facciamoci un nodo al fazzoletto per l’anno prossimo, e finita lì.