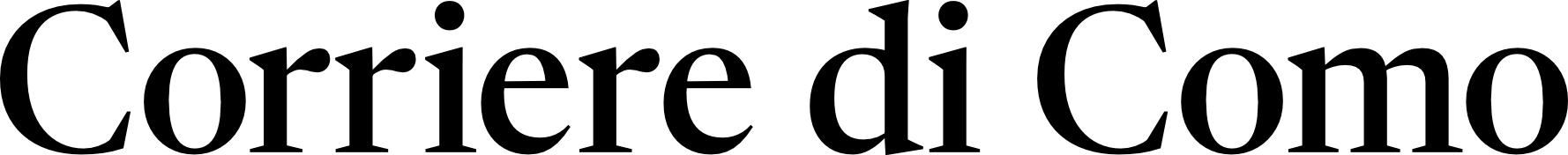La lezione per il tessile: filiera più corta

di Giorgio Civati
Impareremo qualcosa? Dal Coronavirus, intendiamo, potremo
uscirne migliori? Lasciando ai filosofi e comunque a quelli più saggi di noi le
risposte sulle paure profonde dell’uomo, sulla vita e la morte ma anche più
banalmente sulla impossibilità di andare in palestra o a fare l’aperitivo,
tutte cose rimesse brutalmente in discussione di questi tempi, proviamo a
riflettere su una minuscola parte del problema, e cioè se l’economia e più
specificatamente il tessile-abbigliamento impareranno qualcosa, cambieranno
dopo questa crisi.
Primo aspetto: la sempre maggiore interdipendenza di tutto
il mondo, comprese filiere come quella della moda e del fashion. La
globalizzazione, che ora è in crisi profonda. Tra forniture di materie prime,
lavorazioni e vendite la “roba” viaggia più volte in giro per il pianeta.
Guardiamo a casa nostra: i filati? La seta arriva dalla Cina, il cotone
dall’Egitto, le fibre chimiche da un po’ ovunque, Giappone così come Cina o
Stati Uniti.
Ipotizziamo che il tessuto sia made in Como. Venduto a
Milano oppure a Parigi, ma forse pure negli Stati Uniti o in Oriente. E la
confezione? Spesso in Bangladesh, perché è lì che costa meno, o chissà dove.
Per realizzare una gonnellina o una camicia, dunque, il giro
del mondo è assicurato almeno un paio di volte dal momento dell’idea alla
vendita in negozio.
Un via vai planetario dettato da questioni economiche, alla
ricerca del prezzo più basso per ogni passaggio produttivo, che ha sicuramente
una sua logica ma che in queste settimane sta evidenziando anche tutti i suoi
limiti. Inaspettati fino a ieri, perché chi immaginava che il mondo potesse
rallentare, quasi fermarsi?
Per questo, da comaschi decisamente e spudoratamente di parte,
ci piacerebbe che il comparto della moda facesse tesoro di quanto sta
accadendo. Che stilisti e grossi gruppi del fashion riflettessero sul valore, non monetario ma comunque
innegabile, di una filiera il più corta possibile, con fornitori e lavorazioni
e messe a punto stilistiche e produttive “vicine”, anche se più costose.
Per interesse, il settore potrebbe anche rivedere certe sue
impostazioni, ridare lavoro a pezzi di industria più creativi, affidabili,
rapidi e vicini ma ovviamente più cari di altre aree del pianeta.
In un mondo ideale, potrebbe anche succedere. A tutto
vantaggio della vecchia Europa, dell’Italia, di Como. E, però, siccome un mondo
ideale non esiste, lo speriamo ma ci contiamo poco.
Ve li vedete big come Lvmh o Kering, i gruppi francesi che
hanno in portafoglio qualche decina dei marchi più famosi al mondo , accettare
di guadagnare un po’ meno per comperare più stoffe italiane anziché cinesi? O
Dolce & Gabbana, Armani ecc.?
Improbabile e quindi, passata l’emergenza, difficilmente resteranno
strascichi positivi.
Del resto anche noi, tutti noi, come consumatori, mica ci
facciamo tanti problemi di coscienza quando decidiamo i nostri acquisti:
automobili coreane o giapponesi, elettronica americana ma con il “cuore” made
in China, cibo che ha trascorso più ore in aereo che nelle stalle o sui campi.
C’è poco da illudersi, passerà anche il Coronavirus e
cambierà ben poco.