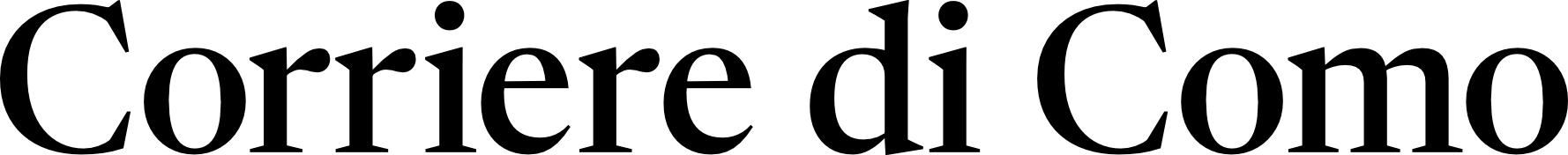Quel novantenne simbolo dell’edilizia monumento all’eterna emergenza

di Lorenzo Morandotti
Due sono i piani di riflessione che si intrecciano di fronte agli imminenti sbarramenti all’ex centrale termica della Ticosa. In primo piano sono le persone che l’abitano abusivamente. Un’aggregazione ai margini della legalità dove è impossibile distinguere chi non ha altra casa e magari nemmeno identità, e chi sfrutta questi ambienti già malsani per attività di pura delinquenza. È la questione umanitaria, sfida quotidiana e ormai non più emergenziale. Che merita, nel rispetto delle norme vigenti, ben altre iniziative strutturali e atteggiamenti di coesione sociale e non va limitata, sia pure in nome del diritto alla sicurezza che è bene sacrosanto di tutti, all’innalzamento di steccati o muri (già si è dovuto combattere contro quello sul lungolago). Muri che una volta realizzati rischiano di evocare e magari anche richiedere, in nome di un’isterica escalation della sorveglianza come unico obiettivo sensibile, ulteriori sbarramenti, magari reticolati di filo spinato e perché no anche cani feroci a guardia del patrimonio culturale. Una barriera non lava la coscienza.
E poi c’è l’altra questione, ciò che la muraglia annunciata va a circoscrivere (sarebbe opportuno anche dire a quale costo vivo per le casse pubbliche): nel macrocontesto dell’area ex industriale della Ticosa, dal destino ancora incerto, è una fetta importante di archeologia e anche, volendo il bicchiere mezzo pieno, un laboratorio urbanistico. Facciamo pertanto un breve ripasso. La centrale termica fu progettata nel 1929 (compirà quindi novant’anni, impacchettata a dovere, nell’ormai imminente 2019) ed edificata tra 1929 e 1930 dall’Ufficio Tecnico della ditta Barosi, specialista di cementi armati. L’edificio, che è l’unico rimasto in piedi del comparto dell’ex Ticosa in mano alla proprietà pubblica, denota una certa eleganza architettonica. Ed è stato salvaguardato e vincolato proprio come reperto di archeologia industriale e simbolo di una fabbrica che diede lavoro e futuro a migliaia di comaschi.
«Dagli anni Duemila la Centrale termica è il rifugio di emarginati (…) che hanno tramezzato lo spazio per ricavarne indecenti abitazioni di fortuna», si legge in una scheda storica di Fabio Cani e Gerardo Monizza, pubblicata sul sito Internet dedicato all’architettura comasca www.jsc15.it.
Dove tra l’altro si chiarisce l’origine del nome dell’edificio: «Alla Centrale termica è stato dato un soprannome – “Santarella” – improprio, perché tratto dal cognome di Luigi Santarella, docente universitario e autore di un celebre manuale sul cemento armato in cui si riporta come opera di pregio, nel terzo volume della terza edizione (1932) e della quarta (1936), proprio la Centrale».
Come avviene per un altro monumento tuttora privo di destino, l’ex cinema Politeama in piazza Cacciatori delle Alpi, non si sa ancora che fare di questa eredità. Negli anni si è fantasticato di farne sede del Museo del Razionalismo, o del Museo della Seta (vista l’origine legata al mondo tessile), addirittura la sede del museo dei trenini Rivarossi mentre nella precedente amministrazione l’assessore all’Urbanistica Lorenzo Spallino fu tra i fautori di una destinazione universitaria, dato che a pochi metri c’è il polo umanistico dell’Università dell’Insubria, che vi potrebbe insediare aule per convegni e la sua biblioteca. Per ora, in versione “burqa”, involontaria beffa al manuale del Santarella, è destinata a rimanere solo un inno al cemento.