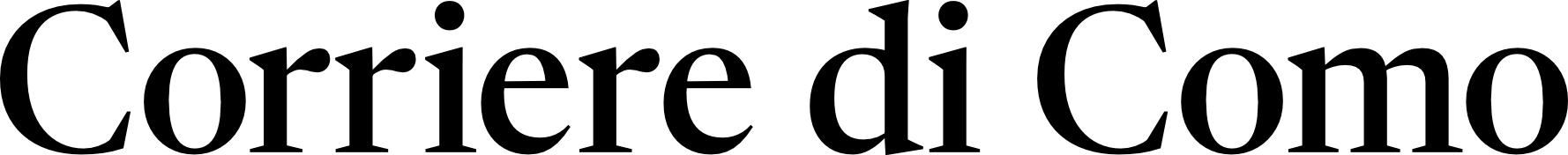Da 18 secoli sono finite le mezze stagioni

di Agostino Clerici
«Devi sapere che il mondo è invecchiato e che non ha più
quel vigore e quella forza sui quali prima poggiava. Ed è il mondo stesso che
parla e testimonia il proprio tramonto. Non ci sono più così tante piogge in
inverno per nutrire le sementi, non c’è più il solito calore in estate per fare
maturare i frutti, né la primavera sorride più del suo bel clima, né l’autunno
è così fecondo dei prodotti degli alberi. Sicchè nessuno deve meravigliarsi che
nel mondo ogni cosa abbia cominciato a venir meno, dal momento che il mondo
stesso ormai è sfiancato e prossimo alla fine». Non sono parole tratte da
qualche manifesto ambientalista del ventunesimo secolo, ma sono l’attestazione
del cambiamento climatico fatta da un vescovo cristiano del Nord Africa,
Cipriano, a metà del terzo secolo. Come? Già diciotto secoli fa le stagioni non
erano più quelle di una volta? Non solo. Se si deve dar credito alla tesi dello
storico statunitense Hyle Harper, la gigantesca costruzione imperiale romana
crollò proprio sotto i colpi capricciosi degli sconvolgimenti climatici che
investirono l’impero a partire dalla metà del secondo secolo. Non le invasioni
dei barbari o la corruzione civile e morale provocarono la rovina dell’impero
romano, dunque, ma furono i prolungati periodi di siccità a spingere le
popolazioni nordiche verso Sud. E fu un cambiamento climatico a rendere i
nuclei urbani sovraffollati l’habitat ideale per la diffusione di germi e
pandemie spaventose che sconvolsero la demografia. Insomma, la colpa fu
dell’uomo, ma anche di un clima che, dopo gli anni del caldo-umido ottimale,
divenne imprevedibile e ingovernabile. Per contestualizzare le parole del
vescovo africano del terzo secolo, bisogna ricordare che egli le scrisse per
difendere i cristiani dalle accuse formulate dai pagani di essere la causa di
cotanti flagelli e dell’imminente fine del mondo. No – scrive il cristiano
Cipriano al pagano Demetriano, mostrando una moderna sensibilità ambientale –
sono solo il frutto di un cambiamento climatico. Del resto, tutte le volte che
finisce un mondo, i nostalgici sono propensi a presagire allarmisticamente la
fine del mondo. Invece sono due cose diverse. I mondi cambiano, il mondo resta.
Ma vale anche oggi per noi, cittadini, divenuti numerosissimi, di un pianeta
malato? La discussione è aperta e si può anche manifestare, più o meno
folkloristicamente. A offrire risposte, però, non può essere la piazza, ma deve
essere la scienza. Servono a poco emozioni belle e passeggere da portare in
giro per le strade con cartelli colorati pieni di frasi fatte. Urgono
motivazioni date da persone che studiano, analizzano, discutono (perché
l’unanimità sui temi ambientali non c’è) e formulano modelli scientifici,
mettendoli sui tavoli della finanza e della politica, cioè di chi può
effettivamente attuare le decisioni per cambiare le cose. Il problema esiste,
sia chiaro, al di là di ogni negazionismo, ma è molto più complesso – sia
nell’impostazione che nella soluzione – di quanto lasci intendere il populismo
ambientalista di Greta Thunberg. «Vi terremo d’occhio», ha detto con tono
astioso all’incontro delle Nazioni Unite sul clima, arrogandosi un ruolo che
richiede un’autorità e una competenza scientifica che la giovane svedese non
ha.