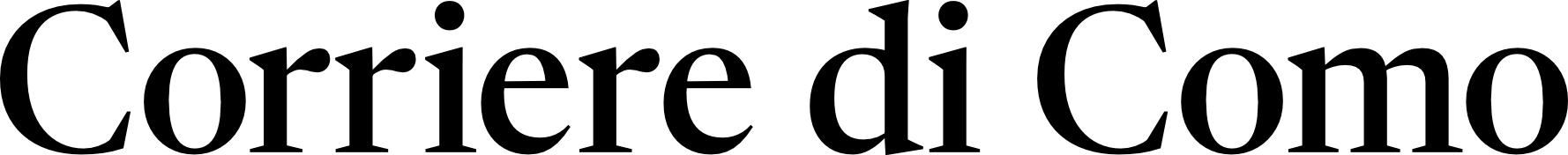Le cabine telefoniche in Ticino sono biblioteche

di Lorenzo Morandotti
Negli anni Sessanta la “gita a Chiasso” era stata
consigliata in un celebre articolo dello scrittore Alberto Arbasino per consentire alla cultura
italiana di colmare i ritardi dovuti al ventennio fascista. Più prosaicamente,
una passeggiata oltre frontiera ai nostri giorni consente di fantasticare su un
uso alternativo delle vecchie cabine telefoniche. Un impiego che da noi suonerebbe quasi fantascientifico dato lo stato di degrado
cronico dei nostri spazi urbani, a malapena curato con pazienza da sparuti ma
indomiti volontari che non si rassegnano e coltivano l’utopia di un Paese
normale, senza spazzatura. Insomma, i vicini ticinesi hanno preso l’usanza
encomiabile di trasformare le cabine telefoniche in disuso in biblioteche in ottavo. Anche nella patria di
Guglielmo Tell il cellulare le ha quasi
uccise e trasformate in luoghi
superflui. Prima di diventare come da noi oggetti esotici e misteriosi, da
smantellare dopo avere svolto la funzione ben poco nobile di vespasiani
improvvisati, si è corsi ai ripari. E così sono in molti casi le sedi di quella pratica sociale che è il
bookcrossing ovvero lo scambio alla pari di libri, che a Como resiste solo in
qualche bar e nella biblioteca civica ma solo perché la struttura non ha spazio
e si libera dei doppioni. Dopo i fiumi di
parole di amore o di rabbia, dopo tante comunicazioni di servizio per buttare la pasta o dire un ritardo, dopo tanti gettoni e scatti alla
risposta, ecco fiumi di parole stampate su carta passare di mano in mano,
gratuitamente. Le hanno ribattezzate
“bibliocabine”, forse perché in Svizzera la lingua di Dante merita più rispetto
e meno anglismi. E sono decine e decine, non sparuti tentativi: le vecchie signore della comunicazione che
hanno ripreso smalto e dignità e una veste forse anche più nobile sono ormai
molte e così vivono una seconda possibilità, una seconda primavera. E danno al
visitatore straniero, all’italico viandante venuto in Svizzera per la benzina,
la cioccolata o per deporre un po’ di risparmi in una banca, l’esempio di una
vita in comunità alternativa, che offre e chiede rispetto, ascolto, attenzione.
Il tutto è nato non per spirito libertario – anche se siamo nella Svizzera
famosa per ospitare anarchici e per realtà come il Monte Verità – ma in virtù
di una legge, che non c’è più: infatti è decaduto l’obbligo per ogni comune di
dotarsi di una cabina. Pronti, via: tanti volontari si sono presi la briga di
riconvertire questi luoghi di oralità dismessa in abitacoli di letteratura
condivisa, da pari a pari. A Lugano, a Mendrisio e anche nella vicina Chiasso
gli esempi non mancano, sono decine. Una volta ho scritto che ogni libro è un
malato immaginario che per guarire aspetta solo di essere letto. Gli svizzeri
sembra che lo abbiano capito.