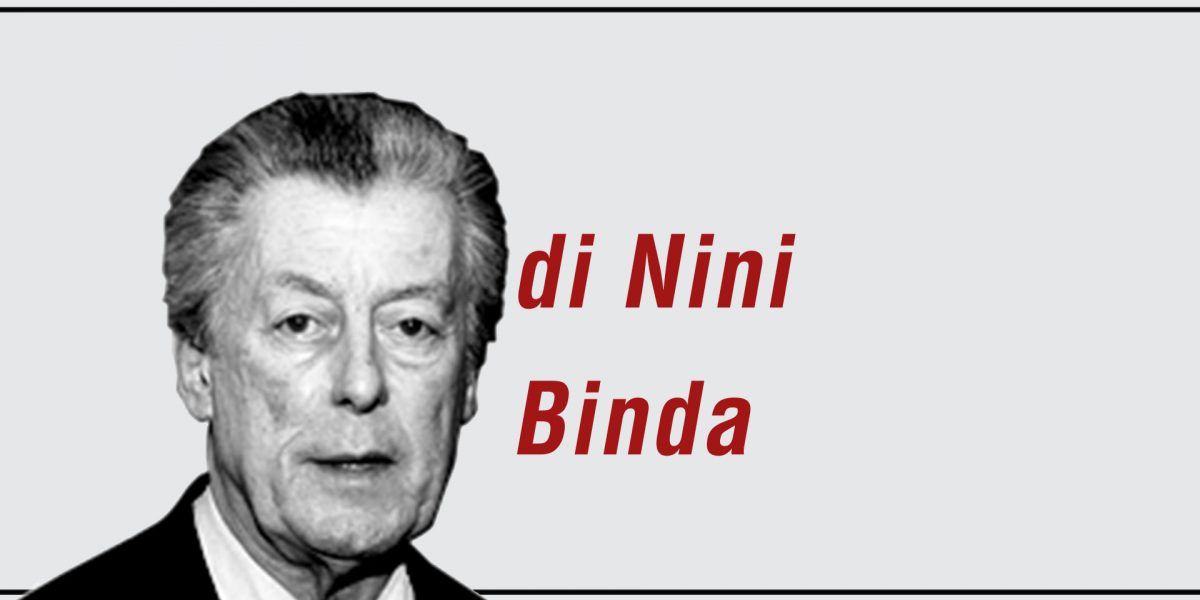di Adria Bartolich
Siamo nell’era dell’individualismo. È un fatto. Una folla di persone, composta da milioni di individui convinti di essere la sola ragione per cui il mondo ancora esiste, si muove disordinatamente e guidata solo dalla convinzione primordiale che gli altri siano un orpello a cui attingere solo in caso di necessità o per potere certificare la propria soggettiva magnificenza. Un incarico, più o meno prestigioso, in fondo ed in sintesi, serve soprattutto a questo. Non a svolgere un lavoro per il quale l’incarico è necessario, non per rendere più funzionale il sistema che si deve dirigere, ma a certificare il proprio diritto di occupare una posizione e di prendere dalla medesima tutto quanto sia possibile in termini di vantaggi, ruolo e prestigio per poi fare quello che si vuole.
Certo, non tutti si comportano così, ma non pochi, invece, si comportano al pari di quei monarchi dell’antichità, stravaganti e capricciosi, a cui la corte e il popolo dovevano obbedienza assoluta in virtù della carica che costoro occupavano. Come in ogni buona monarchia i diritti del sovrano sono estesi anche ai suoi familiari, amici e cortigiani, Va da sé che il momento in cui abbandonare la carica venga inteso come un diritto soggettivo e a totale discrezione dell’interessato, così come le modalità con cui esercitare il ruolo. Per cui capita, a oltre mezzo secolo dal varo della Costituzione repubblicana, che un insigne coniuge di signora collocata in posizioni dirigenziali, a cui viene contestato di occupare un parcheggio al quale non avrebbe diritto, possa terminare la sua arringa contro la malcapitata che gli chiedeva di spostare la macchina dicendo “Lei non sa chi sono io!” – sì, proprio così – e aggiungendo a chiosa titoli onorifici vari, tra i quali spicca quello di marito della dirigente della scuola vicina; oppure che una persona il cui compito dovrebbe essere quello di fare funzionare un’istituzione si dichiari in malattia, e questo è un suo diritto, sparendo però pressoché nel nulla, e sostanzialmente fregandosene sia delle responsabilità che il ruolo le impone, sia del fatto che, alle figure dirigenziali, compete una flessibilità oraria, di disponibilità e di comportamenti assolutamente diversa da quella di chi svolge lavori di tipo impiegatizio. Poco importa se questo atteggiamento comporti un sostanziale blocco delle attività della scuola per le quali occorre l’assenso specifico del dirigente o che queste bizzarrie lascino persone senza lo stipendio.
Se sono titolare di un diritto, che mi viene dato dalla posizione che occupo, lo esercito fino all’indecenza, e tutto il resto vada pure a ramengo. E qui la domanda sorge spontanea: è giusto che una persona così occupi questo ruolo? E ancora, ci sono i livelli gerarchici superiori proprio perché intervengano in questi casi. Ho però la sensazione che dei ruoli piacciano più i vantaggi che le responsabilità a essi connesse.